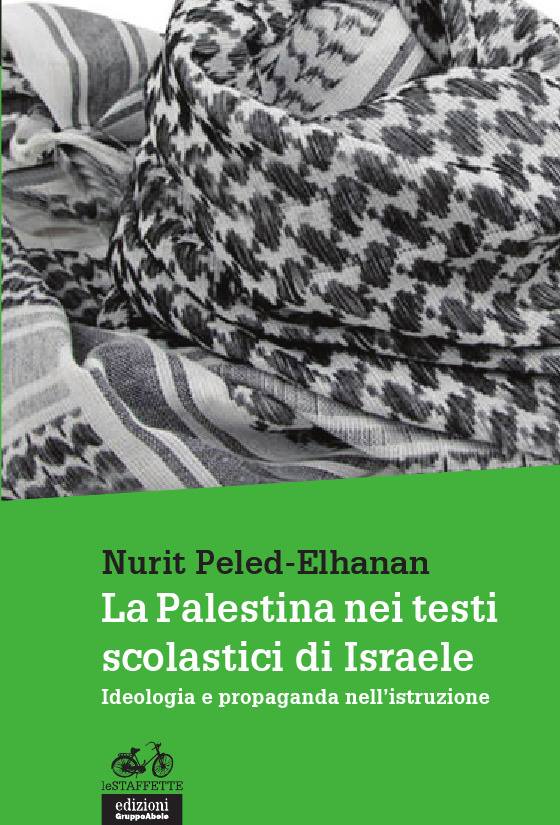Nel suo libro la docente e attivista israeliana Nurit Peled-Elhanan svela il contenuto propagandistico e nazionalista dei testi scolastici adottati nello Stato ebraico, per indagare le radici dell’odio e della paura nei confronti dell'”altro”
di Irene Canetti
Roma, 9 ottobre 2015, Nena News - È appena arrivato nelle librerie italiane il lavoro della docente ed attivista israeliana Nurit Peled-Elhanan: “La Palestina nei testi scolastici di Israele. Ideologia e propaganda nell’istruzione”, edito da GruppoAbele e tradotto da Cristina Alziati.
Il testo, pubblicato per la prima volta nel 2012 nel Regno Unito, rappresenta un’ “inchiesta socio-semiotica”, come lo definisce la stessa autrice, professoressa di Scienze dell’Educazione Linguistica presso l’Università Ebraica di Gerusalemme, che, attraverso uno studio analitico dei principali libri attualmente in uso nelle scuole di Israele, indaga dall’interno il sistema educativo del Paese, e svela, come suggerisce il sottotitolo, il contenuto propagandistico e nazionalista dei testi che plasma la mentalità delle nuove generazioni sin dalla tenera età.
Compiuti i diciott’anni, i giovani israeliani di ambo i sessi sono chiamati a prestare il servizio militare obbligatorio. La legge non prevede il diritto all’obiezione di coscienza e, ad eccezione dei casi di esenzione per gli ultraortodossi, contestati peraltro dal resto della società civile, chi rifiuta di entrare nell’esercito è accusato di tradimento ed etichettato come “refusnik”. La preparazione che porta il ragazzo a trasformarsi in soldato comincia negli asili israeliani, tra i bambini di tre anni: i militari si recano spesso nelle scuole per tenervi incontri più o meno formali, contribuendo già in questo modo alla creazione, nell’immaginario degli studenti, del mito del buon soldato fedele alla Nazione. Questo tipo di formazione viene poi portato avanti principalmente attraverso i loro materiali di studio. Il lavoro della Peled è una disamina di diciassette libri di testo scolastici israeliani, dieci di storia, sei di geografia e uno di educazione civica, pubblicati tra il 1996 e il 2009, nel periodo post-Oslo, che dimostra efficacemente come, attraverso le narrazioni storiche, le cartine geografiche, le immagini, i messaggi espliciti e quelli subliminali, il sistema educativo israeliano costruisce negli allievi sentimenti di identità nazionale, di appartenenza razziale e di odio e paura nei confronti dell’ “altro” e del “nemico” perfettamente rispecchianti le politiche dello Stato.
Dall’indagine semiotica condotta dall’autrice attraverso le tre materie scolastiche, che attinge dai campi della linguistica e della psicologia, della politica e della sociologia, emerge l’univoca strutturazione di due immagini nitide e staticamente cristallizzate, destinate ad imprimersi nella mente dello studente, vittima, secondo Peled-Elhanan, di un autentico “lavaggio del cervello”, e ad influenzare irrimediabilmente le sue future scelte politiche e morali e la sua visione del mondo: l’immagine del popolo ebraico e dello Stato di Israele, e quella dell’arabo, del nemico oltre il confine, del Palestinese, o, meglio, per usare due definizioni che spesso ricorrono nei testi esaminati e che non lasciano spazio a sfumature geopolitiche o storiche, quella dell’”ebreo” e quella del “non ebreo”.
Il “non ebreo”, vale a dire il Palestinese, può essere presentato nelle scuole su due piani: o la sua identità è mistificata e demonizzata, o semplicemente egli non esiste affatto. Gli arabi sono, innanzitutto, rappresentati principalmente attraverso immagini e caricature che, rimarcando antichi stereotipi, li dipingono come contadini o pastori nomadi, in sella a cammelli o seduti sotto a una tenda, restii ad ogni forma di progresso e civilizzazione e membri di una società chiusa e analfabeta che opprime le donne e non conosce leggi. A volte, le foto possono ritrarre arabi col volto coperto intenti a lanciare pietre in operazioni di guerriglia. Nel migliore dei casi, li si ritrae come profughi in strade senza nome. “Nessuno dei libri”, si legge, “contiene fotografie di esseri umani palestinesi, e tutti li rappresentano in icone razziste o immagini classificatorie avvilenti come terroristi, rifugiati o contadini primitivi”. Impressiona anche come, accanto a tali forme di disumanizzazione dello straniero, in base al principio classico secondo il quale ciò che non viene nominato non esiste, nei testi si operi a privare il popolo palestinese della sua attuale identità politica e culturale fino ad oscurarne addirittura la presenza storica e geografica. Raramente, infatti, si parla di “Palestina” o “Palestinesi”: si legge, piuttosto, di “non ebrei”, “arabi”, o di “problema palestinese”. Quello dei Palestinesi, infatti, è descritto spesso come un problema demografico del quale la società israeliana, a causa del disinteressamento dei Paesi arabi, si è dovuta far carico: una rivisitazione storica operata da parte dello stesso popolo che, come nota l’autrice, appena sessant’anni fa era definito come “il problema ebraico” in Europa. Non nominare il nemico che minaccia e dal quale si deve difendere il proprio Paese e non dargli un volto contribuisce, tra l’altro, ad insinuare un odio latente aggravato dalla sua stessa vaghezza: se il timore è il sentimento che si prova verso un pericolo di cui si conosce la natura e l’entità, la paura è una fobia basata sulla sua totale ignoranza e che può più facilmente, per questo, generare atteggiamenti di razzismo, di violenza e sfociare in atti di estremismo.
Quanto all’ “ebreo”, è interessante come la storia e la geopolitica siano tradotte in una memoria e in una geografia essenzialmente sioniste spesso del tutto decontestualizzate, per infondere nel giovane studente o nel bambino un senso di appartenenza alquanto distorto ma difficilmente eradicabile. Nel secondo capitolo, ad esempio, “La Geografia dell’Ostilità e dell’Esclusione”, si analizza il sistematico uso delle denominazioni territoriali di Samaria e Giudea in luogo di West Bank, e l’omissione dei confini geografici con i territori palestinesi; l’intera area è indicata come zona israeliana, spesso non esplicitamente (talvolta il disegno di un Israeliano è collocato all’interno delle frontiere, quello dell’arabo arretrato resta fuori), per insegnare agli studenti a “vedersi come i padroni della Terra di Israele/Palestina, a controllarne la popolazione, (…) e a fare tutto il necessario per incrementare la dominazione ebraica e il suo “sviluppo”, che significa di fatto la sua espansione”. Quanto alla narrazione della storia, essa è quanto mai parziale: si sofferma sui pogrom e sull’Olocausto, e sulla salvezza rappresentata per gli ebrei dal progetto sionista, ma nulla si dice, ad esempio, della storia degli ebrei negli altri Stati, come in quelli arabi, dove a lungo la convivenza tra comunità ebraica ed araba è stata pacifica e armoniosa, con il risultato che anche gli eredi degli ebrei provenienti da quei Paesi, studiando sui testi in uso in Israele, siano convinti di aver subito l’Olocausto. L’ebreo, inoltre, è sempre autoctono, persino il colono arrivato dalla Russia da pochi anni è immortalato come un antico abitante dello Stato. Le guerre e i massacri non sempre sono omessi, talvolta vengono piuttosto legittimati dal loro scopo. L’argomento principale per giustificarli sembra essere il fatto che, per quanto deprecabili, hanno portato dei vantaggi allo Stato di Israele, e qualsiasi altra Nazione, nelle stesse circostanze, si sarebbe ugualmente vista costretta a commetterli. Nei testi in cui viene citato, il massacro di Deir Yassin (1948) è, per esempio, così legittimato: “Il massacro di Palestinesi amichevoli portò alla fuga di altri Palestinesi che rese possibile la creazione di un coerente Stato ebraico”.
Sempre per quanto riguarda la costruzione della personalità dell’ “ebreo” futuro soldato, l’autrice fa riferimento a varie canzoncine, per i bambini più piccoli, che glorificano la figura dell’eroe e del militare in battaglia. La guerra, l’occupazione e la vita nell’esercito sono anch’esse palesemente mistificate. Le foto dei soldati ai check-point in Cisgiordania, ad esempio, ritraggono i militari intenti a prendere il caffè e a chiacchierare tra loro tranquillamente, in uno scenario deserto, in cui i Palestinesi non compaiono mai né si vedono mai allusioni alla loro presenza sul territorio. Del resto, se da un lato il servizio di leva viene presentato come un’esperienza per niente spiacevole, dall’altro i testi non mancano di farsi strumento di minaccia ed intimidazione per chi non volesse prestarsi al suo dovere e pensasse di “tradire” la patria: in uno dei libri analizzati, a fondo pagina in un capitolo, a monito dei traditori è usata la storia di Mordechai Vanunu, tecnico nucleare israeliano che nel 1986 rivelò un piano segreto di armamento nucleare israeliano al Sunday Times, e fu per questo condannato a 18 anni di carcere con l’accusa di tradimento e di spionaggio. La punizione per chi tradisce, suggeriscono i libri ai bambini, è sempre severa e inappellabile.
La memoria storica priva di passato, la politica decontestualizzata, l’appartenenza territoriale slegata dai confini geografici e l’odio verso un nemico innominato e disumanizzato, che emergono dall’analisi dei testi scolastici realizzata in questo saggio, sembrano essere le basi di una società che recentemente pare stia ulteriormente radicalizzando le sue ideologie. I giovani formati sui libri documentati da Nurit Peled-Elhanan sono gli stessi che nell’estate del 2014, durante l’operazione Protective Edge su Gaza, si servivano di mezzi sconosciuti ai loro genitori, selfies e tweets, per esprimere pericolosi incitamenti all’odio e alla violenza, per chiedere “Morte agli Arabi” (anche in questo caso termine usato in sostituzione di “Palestinesi”), per incoraggiare anche attraverso fotografie in pose provocanti i membri dell’Idf, l’esercito israeliano, a fare strage del nemico. Non stupisce l’allarme lanciato dalla scrittrice sull’esacerbarsi della retorica del razzismo e della paura nei testi proposti alle nuove generazioni: per quanto ne siano disponibili centinaia, la scelta dell’insegnante è comunque limitata, in quanto tutti passano, per ottenere il permesso per la pubblicazione, sotto il controllo del Ministero dell’Istruzione, che ne valuta scrupolosamente anche le scelte linguistiche. L’educazione è riflesso della politica nazionale. Issawi Freij, esponente di Meretz, propose nel 2013 addirittura l’introduzione, nell’orario scolastico, di un’ora di lezione di educazione contro l’odio razziale, ma il Parlamento respinse il disegno di legge, il cui scopo, così recitava, era di “eliminare le visioni razziste e sradicare il fenomeno della violenza razzista tra gli alunni e i cittadini israeliani” . D’altronde, l’attuale ministro dell’Istruzione in Israele, Naftali Bennet, non manca di farsi vedere accompagnato in pubblico dai più famosi esponenti dell’estrema destra israeliana e delle comunità di coloni radicali, e non ha esitato ad affermare: “Io ho ucciso tanti arabi nella mia vita e non c’è alcun problema al riguardo”.
L’inchiesta in “La Palestina nei testi scolastici di Israele”, anche alla luce del presente quadro politico e degli atti di violenza compiuti in questi giorni in un clima di tensione crescente, non lascia molto adito a dubbi in merito all’origine delle ideologie facilmente propugnate dai giovani e spiega chiaramente in che maniera il seme della propaganda sia gettato precocemente nella mente dei più piccoli e sia destinato a maturare in odio. E non accorda di certo al lettore la possibilità di nutrire facili speranze riguardo al futuro. Nena News